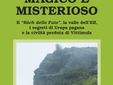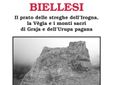Gli esseri fatati in valle Elf non erano solo deformi ma crudeli e violenti.
Secondo la tradizione popolare di Chiaverano una grande fenditura nella Serra morenica che sovrasta il paese detta “Ròch ëd la rovin-a”, pietra della rovina sarebbe stata provocata da un terribile e misterioso popolo di predoni che avrebbe cercato di distruggere il borgo gettandovi sopra un grande masso, per fortuna sbagliando la mira.
Questa stirpe malvagia avrebbe avuto i piedi d’oca.
E’ del tutto evidente che questa tradizione popolare memorizza in forma simbolica un’antico scontro d’etnie fra le genti ‘civilizzate’ della pianura e quelle selvatiche delle “Tan-e dij Afé” della valle dl’Elf, ostili alla pacifica civiltà contadina, violenti ed aggressivi ed acquattati in isolati antri pietrosi sotto la roccia col profilo umano.
Anche nella confinannte val d’Aosta dei Salassi la tradizione popolare indica come rifugi delle fate diverse “Borne”, caverne o fenditure nella roccia come quella di Verrayes considerata un’entrata nel ‘Regno dei morti’.
La ‘bòrna’ valdostana sulla strada dell’ Aouillette a Saint Nicolas é creduta rifugio di esseri fuor del comune; quella di Antey sarebbe stata l’abitacolo d’una fata difesa da un gufo addomesticato. In quella del Pankerot in Valtournanche i montanari inquieti avrebbero avvelenato i figli d’un altra fata o strega che si sarebbe vendicata provocando una grande frana nella montagna, simile a quella del “Ròch ëd la ruvin-a” di Chiaverano.
La criminalizzazione crescente di queste figure che simboleggiano un mondo alpino appartato ed ‘altro’ memorizzava antichi scontri di stirpi rivali e contrapposte ma impediva alla gente del popolo contadino di fraternizzare con gli ultimi ‘resistenti’ pagani.
Malgrado ogni sforzo, in valle dl’Elf sotto una superficiale patina cristiana permangono residui viventi d’un antica, liberatoria ed irrefrenabile attività ludica comunitaria.
Ne fu testimone a fine Ottocento l’eclettico suddito britannico Samuel Butler mentre visitava i principali santuari alpini fra Piemonte e Svizzera ‘italiana’ osservando che nella celebrazione religiosa di Campra di Graglia il momento più spettacolare e partecipato della festa era la così detta ‘baraonda’ che, in contrasto evidente con la spiritualità ortodossa, rappresentava l’esplodere di “tendenze pagane che chiaramente predominavano nella ‘festa’ di Santa Maria della Neve”.
Del resto, ricordava Butler, anche un autorevole contemporaneo, lo scrittore Giuseppe Muratori aveva pur scritto che quella di Campra era “la festa popolare di Graglia, e pochi anni addietro ancora ricordava in miniatura le feste popolari delle sacre campestri del medio evo. Da qualche anno in qua, il costume più severo che s'introdusse in questi paesi non meno che in tutti gli altri del Piemonte, tolse non poco del carattere originale di questa come di tante altre festività popolesche; nelle quali erompeva spontanea da tutti i cuori la diffusiva vicendevolezza degli affetti, e la sincera giovialità dei sentimenti”.
Ma a nulla era riuscito il biasimo delle manifestazioni meno castigate della gioia popolana ed il forsennato sforzo dell’egemonismo per estriparle.
Anche perché nelle località più vicine alle pietrose fortezze degli “Afé” non era mai venuta meno una robusta consuetudine ‘stregonesca’ testimoniata nel ‘600 dalla vicenda del prete-stregone della “Confraternita del Santo Rosario e di Santa Croce” e dalle vicissitudini dolorose di due donne della borgata alpina di Bagneri processate nello stesso periodo come streghe e ‘masche’ dal giudice ecclesiastico don Nicola Velotti, curato di Muzzano, fondatore del Santuario di Graglia, scrittore prolifico e dotto di temi religiosi e devozionali.
Grazie ad un approfondito studio di Giuseppe Ferraris pubblicato nel 1936 sull’“Illustrazione Biellese” sappiamo che le presunte streghe erano madre e figlia, Luigia de Ghittinis e Giovanna maritata Anselmettis e non avevano negato la pesante accusa, confermando, si presume sotto torture almeno psicologiche, di partecipare a feste orgiastiche ed a banchetti di carne umana.
Rinchiusa nel carcere di Vercelli, la figlia appena ventenne aveva ammesso d’aver partecipato a riunioni stregonesche a poca distanza da Bagneri, sopra Donato, “nella Valleggia di Netro”, oltre gli alpeggi di Pollone e Biella; in val di Mosso ed “al di là della montagna nei Vuittoni”, a Donnaz, in val d’Aosta.
Assieme alla madre e molte altre ‘masche’ si sarebbe recata “alli balli et radunanze delle streghe, cioé due volte nella sera del giovedì et le altre in altri giorni della settimana ed andava in questo modo, cioé sua madre l'ungeva sotto li piedi con un olio che aveva in un olletta [...] et poi subito camminava per aria, due volte sopra le spalle della propria madre, et altre volte portata da un non so che, che pareva un gatto”.
Prima di recarsi al convegno “a cavallo del bastone”, sua madre e le streghe più anziane avrebbero rapito un neonato e la povera “creatura ammascata” sarebbe stata portata in una baita dove “scopersero il fuoco che era coperto in detta camera ed essendovi gran brace vi posero sopra la detta creatura ad abbrustolire. Et quella abbrustolita ne mangiarono tutte in compagnia, dandone anche ad essa un pò cioé una quantità della grossezza di una castagna”.
I macabri banchetti sarebbero stati ripetuti spesso e la giovane avrebbe visto “visto ammazzare altre sei creature di cui una a Donazzo et altre quattro nelli Vuittoni et una di esse la ferirono nel collo, et le cavarono il sangue con una cosa che pareva una conchiglia ossia 'lumaga' et quel sangue sua madre che le diede la morte portò di lì a poco con essa a casa et poi lo vuotò nell'olletto ossia vaso dell'unto con il quale si ungeva mentre andava per aria”.
Mentre il cancelliere trascriveva questa storia macabra ed incredibile di streghe antropofaghe la ragazza precisava che dopo il pasto le donne erano uscite “in un prato ov'erano molte altre persone cioé gatte che facevano un gran tripudio confuso con urli gatteschi et con debellar le piote così che faceva si mescolassero, cantassero e ballassero al suono d'una cetra”.
Benché questi racconti fossero la conseguenza d’una visione deformata di fatti reali dopo aver fatto uso di erbe allucinogene, un fondo di verità dovevano pur averlo specie quando la ragazza rievocava momenti collettivi di letizia, godimento sfrenato ed appagamento dell’atavica fame della povera gente.
Tutte queste storie venivano in ogni caso prese sul serio dall’inquisitore che aveva coinvolto nell’inchiesta anche una donna di Sordevolo, Caterina Bossi accusandola d’essere intervenuta ai raduni stregoneschi sulla montagna biellese.
Contro di lei pesava il pregiudizio paesano perché dopo esser rimasta vedova aveva avuto l’imprudenza di risposarsi con Bartolomeo Dal Verna trasferendosi al paese del marito, Graglia dove, secondo un testimone del processo, “li forestieri sono sempre stati malvisti et odiati”.
Figurarsi una vedova contro cui ancora a metà Ottocento se decideva di risposarsi bande di ragazzotti si scatenavano nella così detta “ciabra” ed in piena notte facevano un terribile baccano sotto le finestre dei due attempati coniugi “solo placandosi se gli sposi, facendo buon viso a cattivo gioco, invitano quegli insolenti a spassarsela a spese loro”.
Contro l’invidiata e malvista ‘forestiera’ di Sordevolo, vedova irrispettosa della memoria del defunto consorte, s’erano accaniti diversi testimoni, tutti di Graglia, accusandola d’aver “guastato e stregato” una fanciullino di pochi mesi su cui “parevano impressi li segni delle mani della suddetta”, ritenuta in paese per “masca”.
Le tre povere montanare non sarebbero state le sole streghe della val dl’Elf perché a Muzzano, confinante con Graglia altre donne sessualmente disinibite si sarebbero incontrate clandestinamente coi loro amanti ‘forestieri’ saliti dai “Cèp Sòra” in un pianoro appartato sotto una parete rocciosa nota come “Ròch dle Fate”,
La grande roccia é alta una decina di metri al lato d’un piccolo prato circondato da grandi alberi frondosi ed incombente a precipizio per più di centoventi metri sul “Gurnejvo”, una pozza dell’Elf fra la natura verdeggiante.
La piscina naturale era fino a qualche anno fa mèta di allegre nuotate dai ragazzi ‘daj Cèp Sòra’ ma oggi é praticamente irraggiungibile perché il sentiero che percorrevano un tempo i giovani occhieppesi é ostruito dai rovi e lordato da ogni tipo di rifiuto.
Anche per il fascino che emana, il “Ròch delle Fate” é entrato a far parte a pieno titolo del leggendario biellese perché la tradizione lo indica come il luogo del fatale incontro della gente di pianura con i misteriosi esseri dai ‘pé d’òca’.
Già a fine Ottocento Pertusi e Ratti avevano pubblicato la leggenda su “certi forestieri, che vivevano segregati dai terrazzani e possedevano singolari cognizioni per iscoprir l’oro nelle sabbie dei fiumi e nelle viscere dei monti.
A poco a poco costoro si famigliarizzarono cogli abitanti del luogo e ne impararono la lingua. A solennizzare ed a sancire questa specie di nazionalità loro tacitamente concessa, diedero un gran banchetto, al quale invitarono i principali fra i terrazzani. Levate le mense, cominciarono le danze con accompagnamento di barbari suoni e di mosse bizzarre.
Nel calore delle danze le donne alzarono un poco le gonnelle e posero allo scoperto certi lor piedi fatti a modo di quelli dei palmipedi. Scoppiarono a quella vista le risa ed i motteggi degli invitati; di che offesi gli stranieri, immediatamente radunate le cose loro, se ne partirono, rimproverando i loro ospiti della commessa inciviltà, e dicendo loro che con essi si partiva per sempre il segreto del luogo ove si trovava oro in abbondanza, segreto che era appunto loro intenzione di propalare ai terrazzani prima di congedarsi dal festino”.
Un’altra tradizione raccolta dall’antropologa Virginia Majoli Faccio collocava invece l’incontro-scontro fra i popolani e gli stranieri deformi a Mongrando e si concludeva con la maledizione gettata dalle donne ‘pé d’òca’ profetizzando che “Le fate sn’andran, ma Mongrand snë pentirà: sempre a marcerà sl’òr ma mai lo troverà”, le fate se ne andranno, ma Mongrando se ne pentirà: sempre camminerà sull’oro, ma mai lo troverà”; invettiva che richiama il mito vittimulense del cavallo d’oro occultato agli invasori romani.
Almeno in questo caso, il leggendario potrebbe avere un fondo di verità perché, secondo il geologo Carlo Marco, la tradizione dei “Pé d’oca” nella Bessa “deve forse la sua origine al fatto che gli antichi cercatori d’oro lavoravano con i piedi nell’acqua, probabilmente protetti da calzari allargati e piatti”.
In una preziosa antologia di racconti tradizionali biellesi la scrittrice Maria Pia Coda Forno ha proposto una diversa versione della fiaba con la regina dai piedi deformi aiutata da un serpente a far buona guardia ad un grande tesoro nascosto in una ‘barma’, forse il rifugio delle “Tan-e dij Afé”.
Il tenebroso, appartato ed angusto pianoro prospicente “Roch dla fata” muzzanese appartiene ai sacerdoti salesiani ed é sul retro d’un complesso di edifici di soggiorno, meditazione e studio.
I reverendi padri hanno collocato nella roccia fatata una statuetta della Madonna, cancellando così lo scomodo ricordo d’una sessualità liberata ed il mito d’un popolo scomparso.
Saremo grati a chi vorrà segnalarci realtà analoghe a quelle esaminate in questo articolo scrivendo a storiaribelle@gmail.com
Per approfondire questi argomenti segnaliamo due libri pubblicati da Storia Ribelle casella postale 292 - 13900 Biella.